Home > Giorgio Spini, la missione protestante dello storico
Giorgio Spini, la missione protestante dello storico
Publie le mercoledì 18 gennaio 2006 par Open-Publishingdi Nicola Tranfaglia
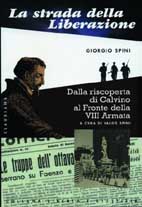
La scomparsa di Giorgio Spini mi dispiace doppiamente. Perché perdiamo uno degli storici maggiori della sua generazione, una generazione particolarmente ricca giacché è quella di Franco Venturi, Alessandro Galante Garrone, Gastone Manacorda (per citarne solo alcuni); ma anche perché, con lui, perdiamo un democratico che ha continuato a credere per tutta la vita agli ideali di giustizia e di libertà .
In un paese, l’Italia, che appare sempre di più come la patria del trasformismo e dell’opportunismo da parte di intellettuali che dimenticano di avere una grande responsabilità di fronte alla comunità e in particolare alle nuove generazioni, l’esempio di uno studioso come Spini è da ricordare con speciale rilievo.
Valdese per antica fede familiare, storico dell’età moderna e del principato mediceo fiorentino, lo studioso appena scomparso partecipa alla lotta di Liberazione come ufficiale dell’ottava armata inglese ed entra a Firenze negli ultimi giorni della battaglia decisiva per la cacciata dei nazisti e dei fascisti.
Negli anni della giovinezza si è accostato ai gruppi liberalsocialisti dell’Umbria e della Toscana in cui viveva l’insegnamento di Salvemini, dei Rosselli e quello più vicino di Aldo Capitini e di Guido Calogero. Di qui il passaggio negli anni della guerra al nascente partito d’azione con Tristano Codignola, Piero Calamandrei e molti altri giovani. E la collaborazione alla rivista del gruppo fiorentino il Ponte che esce proprio all’indomani della Liberazione.
Ma l’avventura azionista termina assai presto e Spini, come molti altri ex azionisti, si avvicina al partito socialista di Nenni e De Martino e combatte le battaglie politiche che portano alla crisi del centrismo e alla nascita del centro-sinistra.
La sua passione politica è autentica ma non così impetuosa e assorbente da distoglierlo dalla sua professione di storico e di professore che lo porta, da una parte, a insegnare oltre che a Firenze nelle maggiori università americane (da Harvard a Berkeley), e dall’altra a impegnarsi con entusiasmo nella scrittura di un manuale di storia per i licei e la scuola secondaria che avrà un grande successo e resterà in testa alle classifiche per alcuni decenni.
La sua Storia dell’età moderna da Carlo V all’Illuminismo pubblicata dall’editore Einaudi sarà l’esempio di come si scrive un libro diretto ai giovani e meno giovani lettori non addetti ai lavori ma appassionati a una narrazione attendibile e piacevole delle vicende dei secoli centrali della storia europea.
Negli anni successivi il suo lavoro di storico si espande in territori non sempre vicini e tradizionali perché accanto ai lavori ricorrenti sulla storia fiorentina nei secoli quindicesimo e sedicesimo, Spini si dedica con passione alla storia americana e, nel 1968, esce una ricerca che rappresenta per molti aspetti il culmine della sua riflessione sugli Stati Uniti.
L’opera, che esce da Einaudi, si intitola Autobiografia della giovane America ed è un lungo viaggio nella ricerca che gli storici americani hanno fatto per più di due secoli, dai Padri Pellegrini all’Indipendenza, sul significato della nazione che hanno creato nel Nuovo Continente. È forse il capolavoro dello storico fiorentino, ma il posto è conteso dagli studi sul principato dei Medici e a Firenze e in particolare dal volume Cosimo I dei Medici pubblicato la prima volta nel 1945 e poi riedito all’inizio degli anni Settanta.
Accanto a questi che appaiono come i lavori centrali della ricerca di Spini rimangono di notevole importanza anche i suoi lavori sul protestantesimo italiano negli ultimi due secoli che colgono con chiarezza alcuni tra i caratteri peculiari della storia italiana vista nel lungo periodo.
Per le nuove generazioni, Giorgio Spini è stato, con i suoi libri ma anche con il suo insegnamento e con la sua attiva partecipazione alla vita pubblica della città e della penisola, un maestro di democrazia e di educazione alla libertà. Non ha mai ceduto ai vizi, assai frequenti nel nostro paese, dell’opportunismo e della mediazione ad ogni costo e ha sempre riaffermato fino all’ultimo la sua immutata fiducia nelle prospettive del socialismo liberale e democratico.
Negli ultimi tempi (ricordo un incontro di due o tre anni fa durante una riunione in Toscana per il 25 aprile) si è sentito più volte amareggiato per l’espandersi di un revisionismo chiacchierone e scientificamente infondato sia sulla storia del fascismo e della Resistenza sia sulle aggressioni crescenti alla Costituzione repubblicana.
Gli pareva, come a molti non soltanto della sua generazione, che l’Italia e gli italiani tornassero indietro e mostrassero un’attenzione eccessiva ai demagoghi e al populismo. Ricordo che ero d’accordo con lui ma che cercavo di essere più ottimista e di intravvedere grandi segnali di cambiamento. Ma lui, che aveva vissuto gli anni della Resistenza e dell’immediato dopoguerra quando le speranze sembrarono realizzarsi almeno in parte, traeva dalla nuova vittoria della destra auspici assai negativi. Mi ricordava, a ragione, i vizi e le tare del nostro paese e insisteva molto sulle insufficienze delle nostre classi dirigenti di fronte ai mutamenti della società. A queste considerazioni lo portava proprio il confronto con la nazione americana e il ripetersi di crisi di regime in Italia ogni qualvolta la classe politica si trovasse di fronte a una svolta difficile.
Ora, rileggendo le sue opere e in particolare quelle americane e quelle sul protestantesimo, dovrò purtroppo fare a meno del dialogo con lui, delle sue sempre nuove osservazioni su quel rapporto tra passato e presente che costituisce per chi fa questo mestiere uno degli aspetti più interessanti e problematici.
http://www.unita.it/index.asp?SEZIONE_COD=EDITO&TOPIC_TIPO=E&TOPIC_ID=46797




